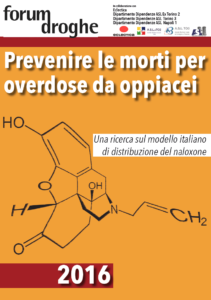 Prevenire le morti per overdose da oppiacei. Il modello italiano di distribuzione del naloxone è il titolo di una ricerca realizzata da Fuoriluogo sull’esperienza italiana di distribuzione del naloxone ai consumatori e nella comunità sociale (Take Home Naloxone – THN).
Prevenire le morti per overdose da oppiacei. Il modello italiano di distribuzione del naloxone è il titolo di una ricerca realizzata da Fuoriluogo sull’esperienza italiana di distribuzione del naloxone ai consumatori e nella comunità sociale (Take Home Naloxone – THN).
Il lavoro nasce dalla necessità di colmare un vuoto di conoscenza, di informazione e di comunicazione attorno ad una esperienza ormai più che ventennale di riduzione del danno (RdD) e di limitazione dei rischi correlati (LdR) all’uso di oppiacei.
La letteratura scientifica sul THN italiano è assai scarna, si limita a pochi studi locali e datati, tanto che le più recenti rassegne internazionali paradossalmente non includono o trattano per cenni una delle poche esperienze nazionali di THN significative in termini di durata, continuità e ampiezza degli interventi. Un esempio emblematico: gli studi citati indicano il 1996 come anno di avvio dei primi interventi di THN in Italia, mentre già nel 1991 gli interventi di strada avevano adottato questa modalità, anticipando quanto sarebbe avvenuto in seguito in altri paesi.
Non è certamente, questa lacuna, responsabilità dei ricercatori internazionali, che avevano ed hanno la difficoltà di reperire fonti e dati sull’esperienza italiana.
Questa carenza ha diverse ragioni, la prima delle quali è di natura politica: come meglio detto nel primo capitolo di questo rapporto, le politiche di RdD in Italia “si fanno ma non si dicono”, come recita un popolare detto italiano. Alle pratiche, agli interventi e ai servizi, diffusi in maniera per altro diseguale nelle regioni del paese, non fa riscontro una chiara politica nazionale di indirizzo che riconosca la RdD effettivamente come uno dei pilastri operativi e un approccio trasversale della strategia nazionale sulle droghe.
La ricerca sulla RdD e dunque anche sul THN sconta questa mancanza di un chiaro indirizzo politico in termini di disattenzione e mancato investimento. Ci sono poi ragioni di risorse insufficienti, di limitati investimenti e di tagli che mettono i servizi in difficoltà e portano gli operatori – che sono anche i primi osservatori ed esperti del proprio intervento – a dover trascurare obiettivi di monitoraggio e valutazione a favore dell’impegno sul campo. E, ancora, una certa debolezza del pur vivace movimento di advocacy per la RdD, che in Italia vede buone alleanze tra operatori, associazioni, consumatori, ma ancora oggi scarsamente incisivo nell’orientare le decisioni della politica. Tuttavia, alcuni vuoti nel campo della ricerca sulla RdD sono stati colmati, negli ultimi anni, proprio da queste reti, per altro con risorse nulle o scarse.
Questa carenza di studi su evidenze e risultati del THN ha anche diverse conseguenze negative, la prima delle quali è la maggiore difficoltà a ottenere sostegno politico alle pratiche di RdD, in una sorta di circolo vizioso; e non secondariamente, si traduce in un deficit di conoscenza ed analisi degli interventi, necessarie agli stessi operatori per adeguare obiettivi, strategie e metodologie di lavoro, al fine di accrescerne i risultati e l’adeguatezza.
L’idea di questa ricerca è nata già qualche anno fa, proprio dalla necessità di valutare, innovare e sviluppare gli interventi di THN in Italia, trovarne punti di forza e di debolezza al fine di accettare la sfida dei nuovi scenari del consumo e della relativa riorganizzazione degli interventi; ma ha avuto negli ultimi due anni un particolare, decisivo impulso quando alcuni di noi, che hanno promosso e condotto questo studio, hanno iniziato a ricevere domande sul modello italiano di THN da diverse parti del mondo: erano ricercatori, operatori o consumatori che si stavano attivando per una campagna globale di advocacy per estendere il THN ai tanti paesi dove non è permesso, o comunque dove non è accessibile. Un obiettivo che fortemente condividiamo, una campagna alla quale aderiamo, e a cui pensiamo di poter dare un contributo basato sull’esperienza. Su questa spinta ci siamo dunque attivati, trovando in due sponsor privati e nelle nostre (limitate) risorse il sostegno necessario.
Questo è dunque un lavoro che guarda in due diverse direzioni: una nazionale, per contribuire allo sviluppo, all’aggiornamento e al definitivo accreditamento del THN in Italia, e una internazionale, per dare alla campagna globale sul THN elementi di informazione e conoscenza. È una ricerca quanti-qualitativa che coinvolge i due gruppi di protagonisti, gli operatori e le persone che usano sostanze; siamo consapevoli dell’importanza di sviluppare una raccolta sistematica di dati e contiamo di continuare a lavorarci, con nuove alleanze e sollecitando una nuova attenzione degli enti che se ne dovrebbero, per mission, occupare. Tuttavia sappiamo anche quanto la ricerca qualitativa possa contribuire alla conoscenza, quando di mezzo vi siano i comportamenti umani, le organizzazioni, l’empowerment, la salute.
Questa ricerca è un nuovo capitolo di quello sforzo “dal basso” teso a colmare un vuoto nella conoscenza che pure ha bisogno di ben più attori (soprattutto istituzionali) e di ben altre risorse.
Consapevole dell’importanza di coinvolgere più attori, Forum Droghe (associazione di advocacy, formazione e ricerca sulla RdD e per la riforma delle politiche sulle droghe) ha promosso un’alleanza con un ente di ricerca (Eclectica), tre Dipartimenti pubblici per le Dipendenze (ASL ex 2 e ASL 3 di Torino, ASL 1 di Napoli) tra quelli maggiormente attivi sulla RdD; e ha coinvolto nel lavoro una ampia rete di operatori, associazioni, servizi pubblici e privati e persone che usano sostanze (tra loro ITARDD- Rete Italiana per la RDD; CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, e, per i consumatori, Isola di Arran e IndifferenceBusters).
Una alleanza che è emblematica del volto positivo della RdD italiana e delle sue potenzialità.
Susanna Ronconi – Forum Droghe
Per approfondimenti: www.fuoriluogo.it



